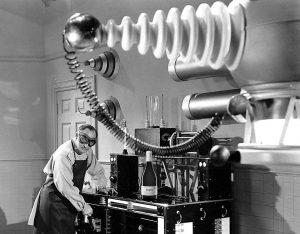 La recente lettera di San Sandro Apostolo – come potrei definire l’illustre collega Sandro Sangiorgi, che vanta la più lunga militanza critica d’Italia grazie a una preziosa opera di studio lunga ormai quasi quattro decenni – ai Corinzi, ovvero l’ultimo scritto sui vini naturali apparso in Porthos, ha generato in pochi giorni centinaia di commenti e interventi assortiti.
La recente lettera di San Sandro Apostolo – come potrei definire l’illustre collega Sandro Sangiorgi, che vanta la più lunga militanza critica d’Italia grazie a una preziosa opera di studio lunga ormai quasi quattro decenni – ai Corinzi, ovvero l’ultimo scritto sui vini naturali apparso in Porthos, ha generato in pochi giorni centinaia di commenti e interventi assortiti.
Nonostante il tono pacato del testo, Sandro ha gettato un macigno, più che un sasso, tra le fila dei sostenitori del vino naturale. Puntando il dito contro l’innegabile deriva di molti vignaioli che rinunciano volontariamente ad indirizzare anche in misura minima l’andamento delle vinificazioni, in nome della più radicale e idealizzata naturalità del processo che porta dall’uva al vino.
I procedimenti fisico-chimici sempre più invasivi e manipolatori dell’enologia ortodossa hanno generato negli ultimi decenni anticorpi fin troppo efficienti, e oggi ci si confronta spesso con la negazione in radice di ogni pratica enotecnica. Quasi che l’atto stesso di guardare una vasca in fermentazione costituisca un’indebita ingerenza umana nel lavoro della natura.
Fino a quando queste ovvie evidenze erano richiamate da giornalisti e critici considerati mainstream, i vinnaturisti più tosti non se ne curavano affatto. Era la difesa d’ufficio della casta, di coloro i quali difendevano lo status quo. Dei fiancheggiatori, quando non dei conniventi prezzolati.
Ma oggi – ohibò – li mette in guardia pure il loro paladino? pure la loro vox clamantis in deserto?
Sandro arriva addirittura a definire molti vignaioli “sciatti”:
“Negli ultimi due anni il numero di bottiglie “topate” è aumentato fino a raggiungere livelli preoccupanti. Protagonisti di questi incidenti sono stati all’inizio produttori e produttrici della nuova leva: incoraggiati dalla spontaneità a prescindere da tutto, hanno rinunciato all’anidride solforosa senza però la minima competenza e consapevolezza di cosa accade tra la vigna e la cantina e durante la fermentazione. Il mercato degli innamorati dei vini naturali si è riempito di bottiglie di sconosciuti interpreti francesi e spagnoli che hanno fatto della sciatteria una specie di marchio distintivo.”
E più avanti, rincarando la dose:
“Parte della situazione ruota attorno all’uso dell’anidride solforosa. Rinunciarvi a prescindere, considerando la scelta un atto eroico e per questo da premiare comunque vada, si sta rivelando un errore paragonabile al tanto criticato uso dei lieviti selezionati senza considerare la possibilità della fermentazione spontanea. I dogmi, gli assolutismi, se talvolta e da qualche parte hanno funzionato, non è stato certo nell’ambito della viticoltura e dell’enologia.”
 Delle belle randellate. Del tutto condivisibili. Ma allora dove finisce l’atto puro e casto del fare vino, il fatto ad arte, e dove comincia l’eccesso di manipolazione, l’artefatto? Come opinione personale virgoletto l’ennesima volta, stancamente, un mio testo di quasi un decennio fa:
Delle belle randellate. Del tutto condivisibili. Ma allora dove finisce l’atto puro e casto del fare vino, il fatto ad arte, e dove comincia l’eccesso di manipolazione, l’artefatto? Come opinione personale virgoletto l’ennesima volta, stancamente, un mio testo di quasi un decennio fa:
“Ogni vino è ottenuto da una elaborazione. Si tratta di valutare fino a quale grado una manipolazione rimane nei confini del buono, del giusto e dell’autentico. Una valutazione non data in astratto una volta per tutte, ma che richiede costante equilibrio critico sulla sottile corda tesa tra i due estremi dell’artefatto e del fatto ad arte. Ovviamente non esiste un punto di vista matematicamente e incontrovertibilmente giusto. Ogni critico, ogni appassionato deve trovare il suo”.
I due estremi della corda sono chiari. Per molti bevitori sono perfettamente accettabili e anzi apprezzabili liquidi pseudo-vinosi trasfigurati da decine di manipolazioni enotecniche, resi inerti e come lobotomizzati nel cliché pulitino-fruttatino-morbidino-dolcino. Per altri se non si avverte alcun afrore selvatico (gnu in calore, ascella di cinghiale, gozzo di cormorano brasato, e simili) non è “vino vero”.
Ai palati più laici e liberi sta trovare il punto di equilibrio interno.





È vero, il fondamentalismo rivoluzionario ha prodotto un movimento di tutto rispetto, che ormai in molti produttori, anche ‘classici’, iniziano a seguire almeno a grandi linee. Al contrario, i fondamentalisti non si evolvono. Però non è tutto così, alcune organizzazioni hanno ammorbidito le regole del vino naturale (regole che o non esistono o non sono mai state codificate o sono differenti da una all’altra). I produttori possono fare quel che vogliono, le uve sono le loro, la fatica è la loro, il rischio anche. Siamo noi consumatori avanzati (nel senso di informati…) che dovremmo iniziare ad essere meno fondamentalisti e intransigenti.